
Maria Giulia Marini (MGM), Direttore dell’Area Innovazione in Sanità della Fondazione ISTUD, ed Enrica Leydi (EL), content manager di ” Cronache di Sanità e Medicina Narrativa”, intervistano il professor Arthur Frank sulle definizioni e il valore della medicina narrativa.
Arthur Frank (AF) è professore emerito presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Calgary ed è stato professore II presso l’Università specializzata VID, in Norvegia. Scrive e tiene conferenze sull’esperienza della malattia, sulla narrazione e sull’etica dell’assistenza. Vive a Calgary, Alberta, Canada. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Yale nel 1975, il master in comunicazione presso l’Università della Pennsylvania nel 1970 e la laurea in inglese presso l’Università di Princeton nel 1968.
È autore di At the Will of the Body (1991), The Wounded Storyteller: Body, Illness, and Ethics (1995), The Renewal of Generosity: Illness, Medicine, and How to Live (2004), Letting Stories Breathe: A Socio-Narratology (2010).
Il suo ultimo libro King Lear: Shakespeare’s Dark Consolations (2022), si occupa di come Re Lear possa aiutare le persone che hanno bisogno di aiuto, senza minimizzare le vulnerabilità, ma piuttosto mostrando ciò che è pienamente umano, e condiviso, nella sofferenza.
In questa intervista:
Narrazione nella Medicina
EL: Come si è avvicinato alla narrativa in medicina? Dove, quando e come l’ha scoperta?
AF: Ho conosciuto i principi della medicina narrativa prima che Rita Charon ne coniasse il termine. Per me è nata da due cose: la mia formazione in sociologia medica e gli anni in cui sono stata malato, quando ho scritto il mio libro di memorie At the will of the body. Più specificamente, le mie esperienze di malattia hanno reso cruciali per me due serie di differenze, ed entrambe sono il contesto del mio interesse per la medicina narrativa.
La prima è che la terapia non è necessariamente cura. C’è una differenza significativa tra curare il paziente e prendersi cura di lui. Ho percepito la differenza nel modo in cui gli operatori sanitari si sono avvicinati a me, per prendersi veramente cura di me o somministrare terapie. Non è una dicotomia, le due cose coesistono l’una con l’altra, ma c’è una differenza e l’ho sviluppata nei miei primi scritti.
L’altra differenza è tra guarigione (cure) e guarire (healing). Nella cura del cancro, la guarigione è definita come un tasso di remissione a 5 anni. Questo ha ben poco a che fare con il senso individuale di guarire. La medicina organizzata (in Nord America dal rapporto Flexner e dalla riorganizzazione delle scuole di medicina su un modello scientifico all’inizio del XX secolo) ha un problema a riconoscere il bisogno di guarire; questo si perde nelle pressioni finanziarie e nei compiti quotidiani più strumentali.
Quindi, il mio lavoro si è sempre concentrato su come la medicina, in quanto sistema istituzionale di cura, possa contribuire a ridurre la profonda alienazione che la malattia induce, anziché intensificarla. Soprattutto per quanto riguarda la cura del cancro, molte persone sentono che il modo in cui sono state trattate nelle istituzioni sanitarie ha intensificato la loro alienazione invece di guarirla.
MGM: Mi ha ricordato il PTSD. Ci sono persone che sono guarite ma hanno ancora il PTSD.
AF: Penso che chiunque abbia avuto una malattia potenzialmente letale sperimenti un certo livello di PTSD. Anche se non userei questo linguaggio perché il PTSD viene usato in modo così generico. In effetti, ho cercato di evitare la parola “trauma” perché ormai tutto viene chiamato “trauma”. È una sorta di inflazione linguistica.
MGM: C’è una cosa che dico sempre ai miei studenti: se la cura è buona, si può morire guariti. La guarigione va ben oltre il corpo fisico. Quando c’è una vera comprensione, quando c’è un vero prendersi cura, quando c’è un vero ascolto, quando c’è una vera relazione intima, si possono risolvere le cose che sono rimaste irrisolte per tutta la vita. Si può morire, ma si è guariti.
AF: Credo che il lavoro di Cicely Saunders e del movimento degli hospice anticipi e risuoni con gli ideali della medicina narrativa. Non è inesatto dire che la medicina narrativa sta cercando di portare molte delle pratiche dell’assistenza Hospice, così come intesa da Cicely Saunders, in altre forme di incontri medici. Ero solito scherzare: perché bisogna essere in fin di vita per ricevere le cure palliative? La medicina narrativa prende sul serio questa domanda.
MGM: È vero! Si ricevono buone cure quando si è nel reparto nascita, si è dimenticati con la propria malattia quando si è adulti, e poi si ricevono buone cure quando si sta morendo. La buona assistenza è solo all’inizio e alla fine. Nel mezzo c’è un’assistenza scadente.
Definizioni
EL: Esiste una definizione ufficiale di medicina narrativa dove lei lavora? E cos’è per lei la medicina narrativa nella sua pratica quotidiana, nel suo lavoro?
AF: La risposta breve è che non lavoro. Sono ufficialmente in pensione da circa 10 anni. Tutti i miei lavori sono contratti a breve termine con le università.
Per quanto ne so, in Canada non esiste una definizione ufficiale di medicina narrativa. Posso capire perché a livello istituzionale una definizione di questo tipo sarebbe utile per rivendicare spazi curriculari, finanziamenti, per chiedere l’assunzione di posizioni, ma mi opporrei all’imposizione di confini intorno alla medicina narrativa. Credo sia importante mantenerla aperta.
Per me, la medicina narrativa è l’applicazione clinica delle scienze umane in medicina. È il caso in cui le scienze umane in medicina si concentrano sull’incontro tra il clinico (sia esso medico, infermiere o altra forma di terapeuta) e qualcuno che, in quel momento, è un paziente.
Ho anche sempre sottolineato che essere un paziente è solo una parte, una piccola parte, dell’essere una persona malata. La vita di una persona malata è molto più ampia. Trovo molto fastidioso quando le persone malate vengono chiamate pazienti, come se non appena viene diagnosticato qualcosa, questo diventi la tua identità significativa. Non è così. Essere un paziente si riferisce solo a quei momenti in cui si è assistiti da un professionista clinico. E si tratta di una piccola parte della propria vita.
La mia definizione di medicina narrativa è che essa colloca le malattie nei corpi e i corpi nelle vite. La medicina narrativa si interessa ampiamente alla vita delle persone, cosa che altre forme di lavoro clinico spesso non fanno. L’assistenza specialistica vuole guardare solo alla parte del corpo che è la sua specialità, mentre la medicina narrativa, per dirla con un termine cinematografico, si sofferma sul quadro generale. La medicina narrativa ritiene di dover conoscere la vita del malato e di dover parlare alla vita del malato. Come ha detto John Launer nell’ultima riunione di EUNAMES, “si chiede prima di consigliare”. È necessario sapere cosa sta già accadendo nella vita di una persona e la medicina narrativa è l’atteggiamento di voler sapere. La medicina narrativa invita il medico a capire progressivamente dove si trova l’umanità del paziente, cosa c’è nella sua vita che la rende interessante e, in molti casi, ammirevole.
L’obiettivo della medicina narrativa è consentire alle persone di conoscere se stesse nel processo di conoscenza da parte del clinico. Il mio lavoro in psicologia sociale mi impegna a sostenere che conosciamo noi stessi attraverso la conoscenza degli altri.
MGM: È come Paul Ricoeur e il riconoscimento di sé?
AF: Credo che questa idea sia nata molto prima di Ricoeur, e in forma più dialogica. L’idea che conosciamo noi stessi nello sguardo riflessivo degli altri risale all’inizio del XX secolo: in Nord America, al lavoro dei pragmatisti, soprattutto George Herbert Mead; in Europa, a Mikhail Bakhtin. Tra i fenomenologi, invece, arriva più tardi.
Strumenti
EL: Quindi, è d’accordo con col dire che la medicina narrativa offre gli strumenti per concentrarsi sul processo e sulla vita degli individui nella relazione clinica?
AF: Sono d’accordo in generale. So che il pensiero medico istituzionale e la formazione medica amano l’idea degli strumenti. Tuttavia, spero che la medicina narrativa cerchi di criticare questo linguaggio chiedendo quali presupposti siano insiti nel parlare in questo modo. Si pensi a ciò che gli strumenti implicano come metafora.
Il miglior filosofo degli strumenti è Heidegger e il suo concetto di equipaggiamento, che ci pone in una relazione strumentale con le cose che poi si presentano come oggetti d’uso, o ciò che Heidegger chiama equipaggiamento. Per me è esattamente il contrario di ciò che la medicina narrativa cerca di fare. Se si riduce la medicina narrativa a un insieme di strumenti, allora si fa del paziente l’oggetto dell’uso di quegli strumenti. Gli strumenti determinano l’agenda, mentre un approccio narrativo non solo permette, ma incoraggia attivamente l’altra persona a stabilire l’agenda. Come dice John Launer, si pongono solo domande che derivano dalla narrazione che si è già ottenuta dal paziente.
Humanities
EL: Qual è la storia delle Medical Humanities? Come le chiamate?
AF: Il termine “medical humanities” è diffuso nel Regno Unito, mentre in Nord America la maggior parte delle persone si riferisce alle health humanities perché i professionisti clinici non medici si sentono esclusi dalla parola “medical“. Health humanities è sentito come un termine più inclusivo.
In questo momento, negli Stati Uniti, l’inclusione e l’equità nell’assistenza sanitaria sono i temi dominanti delle discipline umanistiche della salute. Sempre più colleghi si interessano a come la razza, il genere e la classe influenzino l’accesso alle cure, la qualità delle stesse e i risultati dei trattamenti. In questo senso sono rimasto un po’ indietro perché sono ancora interessato agli incontri clinici diadici. Sono ancora interessato a ciò che in The wounded storyteller si chiama la narrazione del caos, e a chi non vuole ascoltarla.
La bioetica esclude i modi in cui gli esseri umani sono auto-divisi. Vuole il soggetto razionale unificato del processo decisionale etico, invece di comprendere l’essere umano come una creatura radicalmente auto-divisa con una conoscenza inadeguata di se stessa. La medicina istituzionale cerca costantemente di sopprimere e negare le sue relazioni endemiche e conflittuali. Anche se la medicina è piena di conflitti di ogni tipo, ha pochissimo spazio istituzionale per riconoscerli, e ancor meno per trattarli come fonti di cambiamento produttivo. Le istituzioni tendono a vedere il conflitto o come una competizione che può essere incanalata per aumentare la produttività, o come qualcosa da eliminare. In nessuno dei due casi è considerato interessante e fonte di cambiamento.
Invece, ciò che le scienze umane possono fare, quando lavorano in aree cliniche mediche, è favorire il riconoscimento di ciò che è sistematicamente negato ed escluso dal linguaggio medico ufficiale. Anni fa, la rivista Health Affairs ha iniziato una serie chiamata Narrative Matters, in cui le persone venivano incoraggiate a scrivere di politica sanitaria, partendo da un’esperienza personale. Un medico scrisse un articolo anonimo su vari problemi della clinica di salute mentale che dirigeva. Gli dissi che era un articolo eccellente, ma che mi dispiaceva che avesse ritenuto di doverlo pubblicare in forma anonima. Mi rispose: ci sono cose che non si possono dire in medicina.
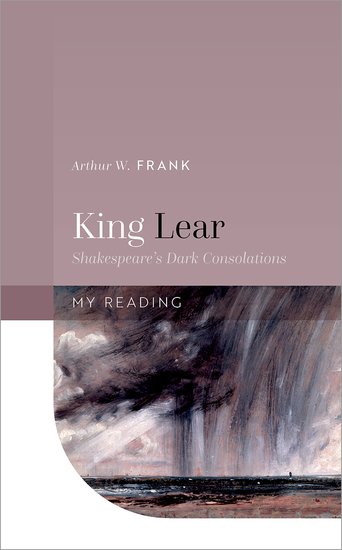
Per me, il compito fondamentale delle scienze umane in medicina è dire queste cose. Non siamo medici, non facciamo ufficialmente parte della medicina istituzionale, quindi il nostro compito è quello di poter dire ciò che le persone che fanno parte di quell’apparato istituzionale non sono in grado di dire. Non ho ricevuto uno stipendio dalle istituzioni mediche e questo mi ha dato un enorme grado di libertà, in termini di ciò che ho potuto dire e guardare criticamente.
Infine, penso che le discipline umanistiche abbiano lavorato troppo per rendersi rilevanti per la medicina. Nelle conferenze che sto preparando, inizio parlando di medicina e poi dedico la maggior parte del tempo a Shakespeare, lasciando che sia il pubblico a sviluppare da solo i termini della rilevanza. Mi rivolgo a persone che vivono una vita ad alto rischio, una vita vulnerabile, come la chiamo io. Hanno bisogni immediati e personali e hanno bisogno di una letteratura che possa parlare di ciò che è caotico, diviso e conflittuale nelle loro vite. Sono queste le vite a cui mi rivolgo parlando di Re Lear nel mio libro appena pubblicato.
tempo
MGM: Cerco di non usare spesso l’espressione “arteterapia”, per le stesse ragioni per cui lei trova la parola trauma inflazionata. Oggi tutto sembra legato alla terapia. Mi piace, invece, parlare di arte che ispira. Di recente abbiamo lavorato su La tempesta e la comunicazione non violenta. Non mi sento a mio agio con etichette come “terapia”, ma purtroppo a volte dobbiamo usare queste parole per negoziare con la controparte, i medici e le istituzioni. Per esempio, quando usiamo la parola “malattia” intendiamo qualcosa di diverso da come i medici concepiscono la malattia. E lo stesso accade con la parola “corpo”.
AF: Sì, i negoziati iniziano con la riconciliazione dei diversi significati.
MGM: Nel precedente incontro di EUNAMES è emerso il problema della mancanza di tempo durante la visita medica. È stata discussa la possibilità di applicare la medicina narrativa durante la visita. Il problema è il tempo. Il tempo è troppo poco o è una questione di atteggiamento e di educazione?
AF: Quando parlo con infermieri e medici all’inizio della carriera, li incoraggio a prendersi due o tre secondi di silenzio con la persona, prima di porre una o due domande basate sulla curiosità. In questo modo, si inizia a creare un racconto della vita di questa persona. Magari prendete un paziente al giorno, quando l’orario lo permette, e dedicate 10 minuti alla curiosità sulla sua vita e su come la malattia si inserisce in quella vita. Consiglio di iniziare con l’unità più piccola.
Una cosa su cui devo essere davvero onesto è che, soprattutto da quando è iniziata la pandemia di COVID, non sono più entrato negli ospedali. Un tempo andavo spesso negli ospedali, a volte invitato a seguire i medici, ma di recente non ho avuto l’opportunità di farlo. Mi rendo conto di non essere in contatto con la pratica clinica quotidiana e sono consapevole che la pratica è cambiata nell’ambiente medico post COVID e che gli operatori sanitari sono stati traumatizzati dal carico di lavoro e da ciò che è accaduto. Credo che l’uso del termine trauma sia giustificato, in parte perché il disagio degli operatori sanitari è troppo spesso ignorato, soprattutto dai governi.
Narrative di caos e restituzione
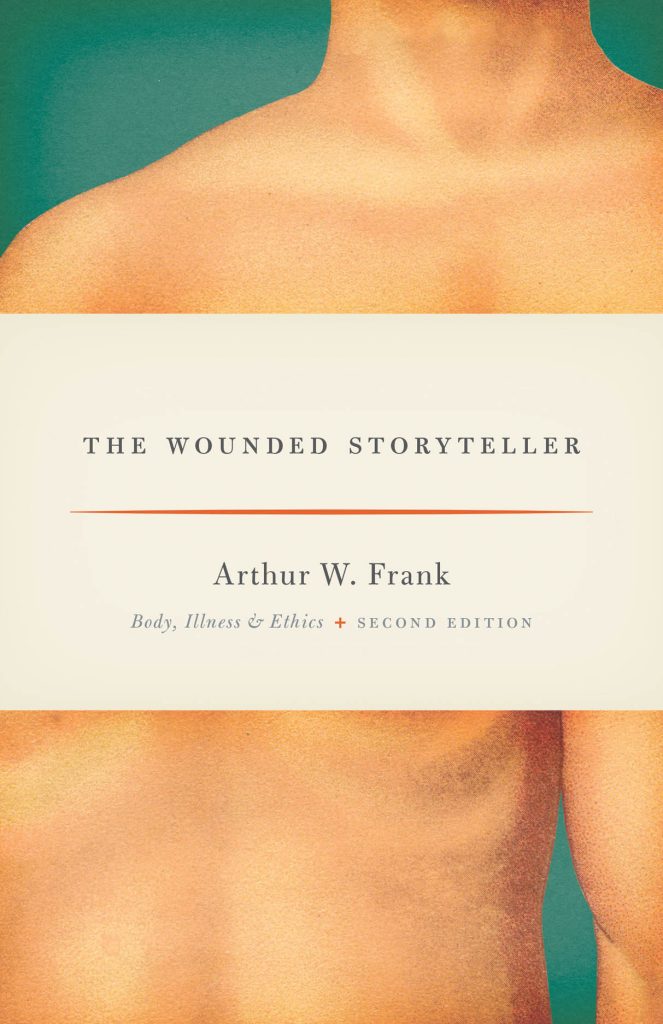
MGM: A proposito di COVID, pensiamo a Bergamo, la città a 60 chilometri da Milano dove c’era il tasso di mortalità più alto d’Europa. Ricordo ancora le ambulanze che arrivavano da lì. Abbiamo lavorato con gli ospedali di Bergamo, facendo scrivere ai medici dei “Diari di malattia” su ciò che hanno visto e vissuto in quei giorni e in quelle notti. Abbiamo lavorato molto con loro e possiamo dire qui la parola trauma perché hanno visto tanta morte. Il problema era che lì non erano nemmeno creduti in Italia: il sud non credeva che ci fosse così tanta morte al nord. È stato molto divisivo… Ora, stiamo ancora lavorando con gli operatori sanitari a Bergamo e anche a Milano, mettendo quadri sui muri per aiutare le persone a lasciarsi andare, perché so che il dolore è ancora lì. Sono rimasto davvero scioccato dal caos narrativo di Bergamo…
Il tuo Cantastorie ferito è una pietra miliare. Oggi volevo parlare con voi della narrazione della restituzione e del riduzionismo del modello biomedico. Con un gruppo di studenti di scienze biologiche abbiamo portato avanti un progetto-lavoro sulla salute nella storia. Abbiamo esaminato il concetto di salute in relazione al valore della vita presso gli Egizi, i Greci, i Romani, nel Medioevo, nel Rinascimento e fino all’età industriale e contemporanea. È emerso che non c’era quasi nulla sulla vita, ma molto sui rimedi, sui farmaci, sui trattamenti e sulle cose legate al modello biomedico. La mia impressione è che il riduzionismo sia sempre stato presente nei secoli. Quindi, possiamo dire che l’umanità è sempre stata invischiata in una narrazione di restituzione. Vuole commentare questo aspetto?
AF: Nel corso del tempo la medicina è diventata sempre più efficace nel curare e ha avuto sempre meno tempo e interesse finanziario a interessarsi ampiamente alla vita del malato.
Louis Thomas, direttore dello Sloan Kettering Cancer Center di New York negli anni ’70, una volta ha raccontato di essere stato uno specializzando in medicina negli anni ’30, prima degli antibiotici. Spiegò che avevano molto tempo da trascorrere con i pazienti e avevano acquisito un buon approccio al letto del malato. Sfortunatamente, non potevano fare molto per loro, dal punto di vista terapeutico. Man mano che la medicina diventa sempre più tecnologica, l’uso della tecnologia esclude il dialogo con i pazienti sulla loro vita.
Oggi il medico media la vendita di beni e servizi tra le aziende farmaceutiche, i fornitori di apparecchiature e il paziente. Negli Stati Uniti l’altro grande attore di questa mediazione sono le compagnie di assicurazione. In Canada, dove c’è un unico terzo pagante, è più semplice, ma è comunque un fattore importante.
Quindi, hai ragione: queste cose c’erano già prima. La domanda è: quando si arriva a un momento di soglia? Direi che tali momenti includono lo sviluppo degli antibiotici alla fine della Seconda Guerra Mondiale e più tardi, negli anni ’50 e ’60, la fine della visita a domicilio, quando i medici non si recavano più di routine a casa dei pazienti.
Poco dopo il momento in cui i medici hanno smesso di andare a casa delle persone, hanno inventato la categoria professionale della medicina di famiglia. Si potrebbe cinicamente sostenere che si trattava di una sorta di meccanismo di compensazione. Qui arriviamo a ciò che la medicina narrativa deve riprendere. In passato, i medici vedevano i pazienti dove vivevano la loro vita. Ora il paziente appare già vestito in una stanza d’esame spoglia, e lo sguardo del medico è diretto immediatamente verso l’area del corpo sintomatica o da trattare.
Negli ultimi 10 anni c’è stata anche l’intrusione del computer nella sala di consultazione. In Nord America, e in particolare negli Stati Uniti, l’incontro con il medico è fortemente programmato da messaggi su uno schermo e il tempo è regolato dallo schermo. Il medico ha poco tempo per completare un compito prima che lo schermo lo avverta che non si sta muovendo abbastanza velocemente. In questo modo il paziente diventa il prodotto di un tempo rimborsabile. Ma il luogo in cui questo avviene rimane ampiamente distribuito. Questo ci riporta a ciò che la medicina narrativa cerca di contrastare.

Ottimo