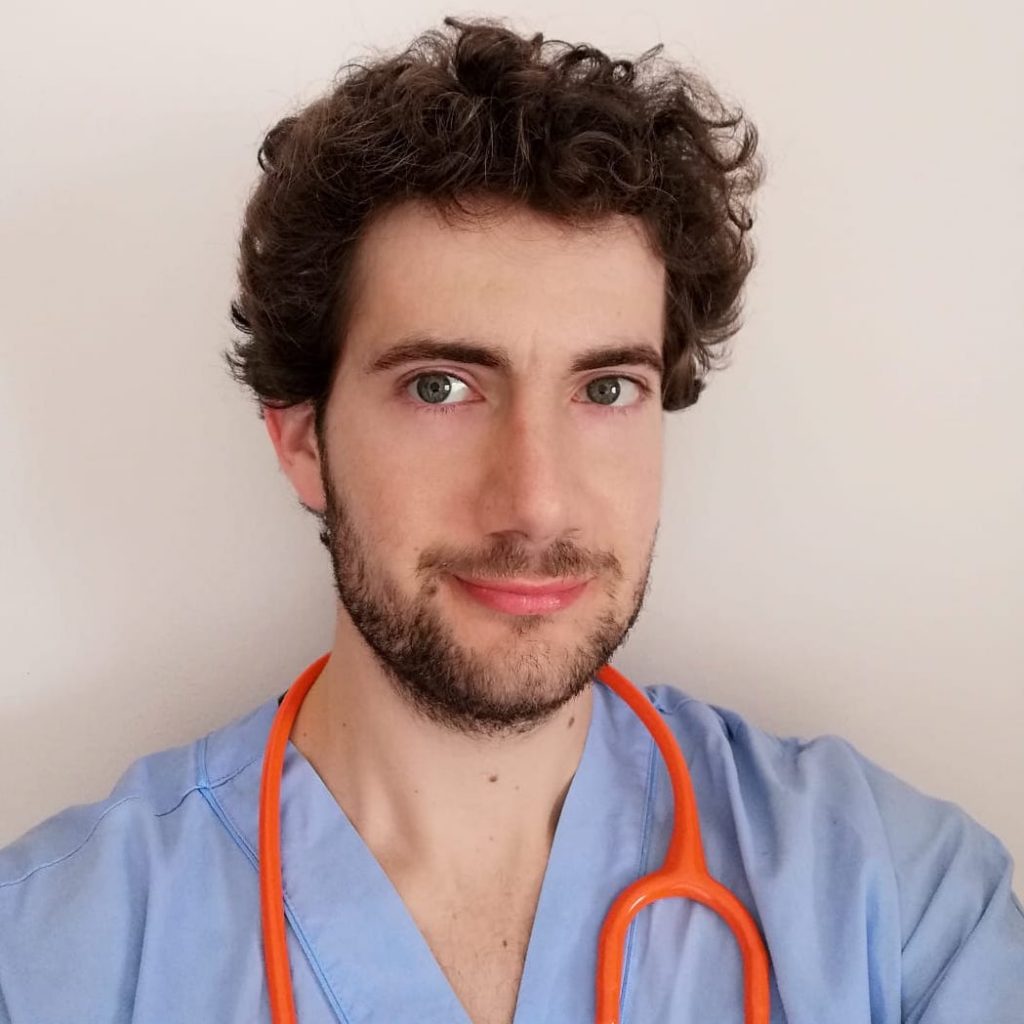
Intervista a Galileo Vergari, giovane laureato in Medicina presso l’Università di Bologna nel 2019; operatore nelle USCA, Unità Speciali di Continuità Assistenziali, da maggio 2020 a febbraio 2021 durante il COVID; ora specializzando in Anestesia presso l’Università di Bologna, con turni a Cesena.
Quale è stata la sua esperienza in questo anno di Covid-19?
Ho trascorso i primi due mesi di lockdown, a partire da marzo, a Bologna per poi decidere di spostarmi e iniziare l’attività lavorativa nelle USCA [Unità Speciali di Continuità Assistenziale, N.d.R.] in Puglia, mio primo vero incarico lavorativo, durato fino a febbraio 2021, quando sono tornato in Emilia-Romagna per iniziare la specializzazione in anestesia, tuttora in corso. Durante il lockdown preparavo l’esame per la specializzazione e seguivo anche alcune lezioni per conoscere e capire cosa fosse il Covid: ero più interessato a queste ultime che a studiare materie inerenti al test. Nelle USCA si trattava di valutare a livello domiciliare i pazienti Covid. In tutto il primo periodo, da maggio fino ad agosto, i numeri erano irrisori, mentre da fine agosto, inizio settembre, abbiamo cominciato a lavorare più intensamente, fino a arrivare a novembre, mese in cui abbiamo anche sforato i turni; a circa fine dicembre, inizio gennaio si è ridotta la mole di lavoro restando stabile fino a febbraio, data in cui io sono partito per iniziare l’attività da specializzando in anestesia a Cesena, dove sono stato mandato in turnazione dall’Università di Bologna, presso la quale ho vinto la borsa. Inizialmente stavo soprattutto in sala operatoria, intorno alla quale sarebbe incentrata l’attività del primo anno, perché a febbraio-marzo non c’era ancora la terza ondata. Quando questa è arrivata, sono state chiuse alcune sale operatorie e abbiamo cominciato a “fare reparto” di medicina interna Covid, sia diurno che notturno – e quelle sono state le prime notti che ho fatto in ospedale. Tutt’ora questo è quello che faccio: attività di sala operatoria, reparto di medicina interna Covid, e da un paio di settimane, ho iniziato anche a fare vaccini per il Covid.
Quali sono state le emozioni e le risposte della mente e del corpo a questa situazione anomala?
Allora, sicuramente, il primo periodo di lockdown è stato il più pesante perché siamo stati chiusi tanto tempo, nonostante le condizioni non fossero troppo negative per me perché ero in casa con qualche amico. È stato però alienante: si sono alternati momenti di umore depresso ad euforia. Nel periodo estivo, giugno-luglio, di normalizzazione a allentamento delle restrizioni, ero in Puglia, e sembrava quasi che il Covid fosse svanito. Poi la situazione è andata di nuovo peggiorando, con la seconda ondata e la ripresa del lavoro. In ogni caso, preferivo lavorare, avere una vita attiva, nonostante i rischi collegati al Covid (contrarlo e trasmetterlo ad amici e genitori), piuttosto che rimanere chiuso in casa a far nulla. È stato molto appagante dare “il mio contributo alla causa”, ma anche semplicemente portare un po’ di conforto a persone che stavano male, sia per la patologia, sia per la stigmatizzazione della malattia, per come viene vista in una città piccola quale quella dove ero [Nardò, in provincia di Lecce, N.d.R.]: quando si diffonde l’informazione che una famiglia è positiva e tutto il vicinato lo viene a sapere, i malati vengono spesso marginalizzati e guardati male. Quando poi mi son spostato per la specializzazione, il ritmo lavorativo è aumentato di intensità, le mansioni erano diverse ed è stato abbastanza deprimente come periodo, soprattutto all’inizio: mi sono venute a mancare la famiglia e gli amici più intimi e ho dovuto costruire nuovi legami. È stato difficile anche quando ci hanno messo a fare il reparto Covid: tornavo a casa dopo dodici ore di lavoro stancante ed era difficile trovare il momento per staccare e rilassarsi con l’unica compagnia dei miei coinquilini che ancora non sconoscevo bene.
Quale è stato il ruolo del gruppo, della comunità di colleghi, nell’affrontare la situazione?
Posso rispondere soprattutto in relazione all’esperienza delle USCA. Il servizio è stato attivato a maggio e siamo stati tutti nuovi reclutati, tutti ci siamo trovati ad affrontare questa nuova esperienza e siamo rimasti quelle sei-sette persone fino a gennaio, e quindi si è creato un bel legame: è stato un qualcosa di nuovo che abbiamo affrontato tutti insieme, un lavoro, mai fatto da nessuno prima. Inoltre, se il Covid è arrivato a marzo e noi abbiamo iniziato a lavorare a maggio, inevitabilmente era un lavoro nuovo in qualunque modo lo si consideri. Ci siamo quindi fatti forza a vicenda. Effettivamente, penso che fosse fondamentale che i turni fossero organizzati sempre in due persone, che non si fosse mai soli, perché ci si faceva molta forza a vicenda: stare con la tuta [la tuta sterile indossata dagli operatori sanitari per evitare il contagio, N.d.R.] quasi sei-sette ore andando in giro a visitare persone è parecchio impegnativo. Si tratta poi di persone che stanno male, bisogna valutare attentamente, spesso ci si trovava anche in situazioni spiacevoli con la famiglia che non voleva ricoverare i propri cari malati perché avevano paura degli ospedali, paura di non rivederli più. Con i colleghi in turno ci si faceva forza e quindi questo ha effettivamente unito molto.
Come ci si pone e si agisce davanti a qualcosa di sconosciuto come il Covid? Le competenze che aveva e che ha ora erano adeguate alla sfida offerta dal virus? In che cosa ci si è dovuti adattare?
Parlo sempre in relazione all’attività delle USCA, all’inizio avevamo tanta voglia di iniziare, di vedere, programmavamo tutto nel dettaglio, lavoravamo tanto di mente, però c’erano pochi casi. E puoi programmare quanto vuoi però finché le cose non le metti in pratica non riesci nemmeno ad individuare concretamente le criticità… Piano piano iniziando a fare le visite, vestizione e svestizione, la paura di infettarsi è diminuita e abbiamo imparato a gestire meglio la visita, i pazienti, abbiamo capito che sei davvero protetto dai dispositivi di sicurezza. Per quanto riguarda gli strumenti, sono stati pochi, ma quelli che avevamo bastavano. Come competenze mi sentirei di dire di sì, che erano adeguate: la valutazione era abbastanza semplice, nel senso che le cose che importano maggiormente sono l’esame obiettivo cardio-polmonare e la saturazione. I casi da ricoverare, che non erano cioè gestibili a domicilio, erano facilmente individuabili. Poi ci sono sempre le situazioni “grigie” che creano problemi… Più che altro gli strumenti terapeutici sono pochi: non ci sono farmaci che possano cambiare effettivamente la prognosi, si poteva solo lavorare di prevenzione, per le infezioni batteriche o le trombosi e iniziare l’ossigeno terapia. Ovviamente, gli ostacoli sono stati soprattutto all’inizio: ad esempio, nell’organizzare un servizio infermieristico adeguato perché i pazienti da gestire a casa sono tanti e, tra le altre cose, è importante effettuare gli esami ematici ma questo all’inizio era assolutamente impossibile, oppure fare delle medicazioni o insegnare a fare le punture. Queste sono state le criticità.
Come ci si è sentiti ad essere parte della categoria dei giovani medici neoabilitati?
Nel primo periodo della prima esperienza lavorativa, mi sono sentito profondamente insicuro e non pronto a gestire un incarico lavorativo: ci si sente un po’ lanciati nel vuoto. I tirocini si sono fatti, ma non ne esci in grado di fare: un conto è vedere le cose, un altro essere da soli, saperle gestire ed averne la responsabilità. Quindi, all’inizio, sicuramente la paura è tanta soprattutto di sbagliare, di nuocere; però gradualmente svanisce e un po’ di sicurezza subentra una volta che si inizia a fare un lavoro e si prende un po’ di confidenza. Va lentamente migliorando insomma, ma rimane sempre molto da imparare, molta esperienza da fare. La cosa importante penso che sia riuscire a discriminare da subito le situazioni che sono veramente rischiose in modo da prendere le giuste misure e regolarsi di conseguenza.
Come ci si sente a intraprendere la carriera dell’anestesista proprio in tempo di Covid?
Ci si sente di avere una grossa responsabilità dal momento che, come sappiamo, i pazienti Covid più critici finisco in terapia intensiva e quindi sono soprattutto gli anestesisti ad occuparsene, ovviamente affiancati da tutte le altre figure. Si è una delle figure principali a contatto con i pazienti più gravi, quelli che poi rischiano di morire sul serio. Penso che anche se non ci fosse stato il Covid avrei considerato anestesia, ma allo stesso tempo la pandemia mi ha portato a considerarla con un occhio di riguardo, o comunque da una nuova prospettiva.
Cosa ha dato e cosa ha perso in questo anno?
Cosa ho dato e cosa ho perso in quest’anno? Penso di aver dato una mano per quanto era nelle mie capacità, il mio contributo, per quanto piccolo, nell’aiutare le persone in questa pandemia, che fosse capire se un paziente fosse da ricoverare, prescrivere un farmaco o dare semplicemente una parola di conforto a un paziente positivo chiuso in casa da un mese. Ho dato un contributo attivo sebbene magari irrisorio. Ho perso tante occasioni per vivere l’età che ho (i miei 27 anni!) Ho perso la possibilità di viaggiare, di andare a concerti, ma anche di incontrare amici che non vedo da tanto e dai quali ho inevitabilmente preso un po’ le distanze a causa della lontananza. Insomma, ho perso un po’ di occasioni di vita, ho perso un po’ di vissuto, ecco. Però ho anche fatto tanto esperienza lavorativa: anche lavorando, anche con il Covid, ho conosciuto persone che altrimenti non avrei incontrato.
