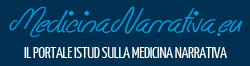Breve recensione del libro “Non-violent Communication and Narrative Medicine for Promoting Sustainable Health” di Maria Giulia Marini
Il linguaggio violento è oggi di gran moda. Aiuta i politici maleducati a guadagnare più voti (vi ricorda i discorsi di Trump?) o i vergognosi talk show televisivi ad aumentare gli ascolti. In altri casi, il linguaggio violento che si può trovare sui social media è sintomo di risentimento e frustrazione, che portano alla denigrazione o addirittura al cyberbullismo. Più comunemente, può essere dovuto a una sorta di pigrizia nel cercare parole giuste e comprensibili e spiegazioni più chiare.
Ma le parole hanno un grande potere: possono ferire o curare, possono escludere o includere e costruire cooperazione, possono ingannare o trasferire informazioni e generare comprensione.
Maria Giulia Marini, con grande sensibilità, ci guida con il suo libro attraverso un percorso di apprendimento della comunicazione non violenta, con una particolare, ma non esclusiva, attenzione alla relazione tra paziente e operatore sanitario. Lo fa non solo con esempi tratti dalla letteratura, dai film o dagli eventi dei nostri giorni, ma anche invitandoci a praticare con esercizi molto coinvolgenti.
L’autrice inizia in modo molto originale con il protagonista de La tempesta di William Shakespeare, il mago Prospero, duca di Milano, che prende coscienza delle proprie e altrui azioni e delle emozioni a esse associate, che lo portano a compiere una violenta vendetta, seguita alla fine dal perdono dei suoi nemici. Ci sono tre elementi importanti in questa narrazione: i fatti, le emozioni e la necessità. L’osservazione dei fatti (fact-checking), le emozioni e la comprensione dei bisogni conducono Prospero (e il lettore) alla pace e all’armonia.
Questa originale introduzione ci guida lungo la strada della comunicazione non violenta: in qualsiasi relazione, dalla famiglia all’ambiente di lavoro, un’attenta osservazione e valutazione dei fatti, la comprensione dei sentimenti che stanno dietro ai fatti e i relativi bisogni e richieste rappresentano la base di una relazione non violenta. Il punto di partenza è l’ascolto attento, che ci permette di capire e valutare. In ogni discussione e in ogni interazione è fondamentale.
Questo è particolarmente importante nella relazione paziente-operatore sanitario, che è asimmetrica per natura. Anche il semplice uso dell’imperativo usato per raccomandazioni e prescrizioni può essere violento.
Ma come possiamo raccogliere la vera “patografia” della malattia di una persona? La Medicina Narrativa offre un’opportunità stimolando con storie parlate e scritte la raccolta non solo di fatti ma anche di pensieri, credenze, sentimenti, aspettative e atteggiamenti. La medicina narrativa ci aiuta “a sfuggire al confinamento di un modello biomedico standardizzato, e a incorporare invece nella pratica della medicina le dimensioni biologiche, sociali, psicologiche ed esistenziali di una vita multiforme e sfaccettata”, per usare le parole stesse di Marini.
La Professoressa Marini lo dimostra con grandi esempi, come il ritiro sociale, autoinflitto (Hikikomori) o imposto da un’epidemia (Covid-19), o il linguaggio usato con gli anziani, come la comunicazione non violenta può aiutare a suscitare narrazioni. E le narrazioni non sono fini a sé stesse, e non solo sono importanti per conoscere meglio la persona con cui abbiamo a che fare, ma forniscono anche un po’ di guarigione alla persona che abbiamo di fronte e anche a noi stessi.
Oggi alcuni hanno suggerito, come ricorda la Marini, che i robot e i computer potrebbero prendersi cura dei pazienti, soprattutto di quelli con malattie croniche. Un robot non può sostituire un operatore sanitario empatico. Tuttavia, un robot può essere preferibile a una persona violenta che invece dovrebbe prendersi cura di un paziente o di un anziano. La telemedicina è meglio di nessun consulto medico, anche se non può sostituire il contatto umano. In ogni caso, l’empatia può essere trasmessa attraverso un teleconsulto a distanza se si basa su una comunicazione non violenta e su un ascolto attento. Il “segreto” è umanizzare lo strumento tecnologico ed evitare di sostituirlo al rapporto paziente-professionista sanitario. L’intelligenza artificiale (AI) può essere d’aiuto: la Marini riporta nel suo libro uno studio trasversale che ha messo a confronto le risposte di medici e l’AI alle domande dei pazienti, dimostrando che le risposte dell’AI erano preferite a quelle dei medici.
Una recentissima pubblicazione sul New England Journal of Medicine (A. Kumar e altri, 23 gennaio 2025) ha analizzato il ruolo dell’AI nella stesura di note di dimissione in un linguaggio semplice. Anche questo studio ha dimostrato che l’AI era più chiara ed esaustiva del medico curante. È vero che le note di dimissione non sono affatto empatiche, ma il ruolo di un professionista della salute che le spiega con empatia e capacità di ascoltare e comprendere le emozioni e i bisogni del paziente non può essere sostituito dall’AI.
La comunicazione violenta non passa solo attraverso la mancanza di rispetto, ma anche con l’uso di parole tecniche, il tono di voce, la costante fretta degli operatori sanitari, la durata ridotta delle visite mediche ma i lunghi tempi di attesa, la scarsa attenzione ai temi della vita del paziente, l’uso routinario dei protocolli, le procedure burocratiche che richiedono tempo, o, persino, le molestie palesi o mascherate.
Ma la comunicazione può essere aperta, assertiva e sicura di sé, in alternativa a quella passiva o aggressiva. Ma, purtroppo, afferma Marini “portiamo dentro di noi, nel nostro DNA, sia i vettori dell’aggressività per la sopravvivenza che quelli della cooperazione per lo sviluppo, e questo ci porta inevitabilmente a comportamenti diversi”.
L’accattivante e stimolante libro di Maria Giulia Marini si conclude con altre due chicche: la prima riguarda i molteplici aspetti dell’intelligenza, ciò che accomuna le persone geniali e come l’intelligenza multipla possa essere applicata alla comunicazione non violenta. La seconda e ultima chicca riguarda la “pace” e la necessità di costruire fiducia e dialogo reciproco.
Un ultimo spunto sullo stile di scrittura di Maria Giulia Marini: è tale l’importanza che Marini attribuisce alle parole che spesso ci fornisce un’indagine accurata sull’origine di alcune di esse, offrendoci la possibilità di comprenderne il vero significato.
Buona lettura!
Alessandro Gringeri – Physician, hematologist, clinical and medical affairs lead