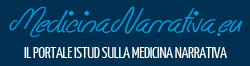Venti giornalisti e comunicatori raccontano cos’è per loro la violenza inconsapevole. Il progetto indipendente di medicina narrativa fa emergere l’esigenza di maggiore formazione e richiama gli impegni dell’Agenda 2030.
Milano-Vicenza, 26 febbraio 2025 – Salute: “lotta, guerra, male oscuro, brutto male, lottatore, lunga battaglia, male incurabile, lotta al cancro”. Ambiente: “salviamo il pianeta, la terra ha la febbre, crisi, negazionista, colpa, piccole azioni, bomba d’acqua”. Ricerca scientifica: “per la prima volta uno studio dimostra, ora la scienza lo conferma, svelato come, è scientificamente provato, nuova cura disponibile in Italia, in arrivo il primo trattamento per, lotta ai big killer”.
Queste sono solo alcune parole di ‘slow violence’, suddivise in macrocategorie, che sono scaturite dal progetto indipendente di medicina narrativa applicata condotto da Silvia Pogliaghi ed Elena Trentin, giornaliste scientifiche freelance. Intitolato Scienza, Media e la grammatica della Slow Violence: riflessioni sulle forme di sensazionalismo nella comunicazione, è stato svolto nell’ambito del XV Master in Medicina Narrativa Applicata di Istud Sanità e Salute.
Lo spunto per il progetto è arrivato da un tema portato alla luce in ambito ambientale dallo studioso Rob Nixon. È stato lui il primo a parlare, nel 2011, di slow violence definendolacome “una violenza che avviene gradualmente e lontano dagli occhi, una violenza di distruzione ritardata che si dissipa attraverso il tempo e lo spazio, una violenza che crea attrito e che di solito non è considerata affatto violenza”.
La slow violence potrebbe essere tradotta in italiano come ‘violenza inconsapevole’, ma in un’epoca in cui si parla di comunicazione non violenta quanti la conoscono? Il progetto ha evidenziato che la slow violenceè un’espressione sconosciuta alla grande maggioranza dei giornalisti e comunicatori scientifici, i quali tuttavia non si sono sottratti dal cercare di decifrarla, guidati da una traccia semi-strutturata, riportandola entro i confini del proprio lavoro quotidiano. Così facendo, hanno contribuito a disegnare un quadro delle sue declinazioni, del suo impatto sulle persone e delle prospettive per il futuro. Tra queste ultime rientra la richiesta, quasi unanime, di saperne di più sulla violenza inconsapevole attraverso una formazione specifica.
“Abbiamo voluto dedicarci a questa tematica ispirate dal libro di Maria Giulia Marini, Non-violent Communication and Narrative Medicine for Promoting Sustainable Health, Ed. Springer Nature, 2024, in cui la slow violence viene esaminata sotto il profilo della comunicazione sanitaria, spiega Silvia Pogliaghi. Con il nostro progetto abbiamo pensato di fare un passo oltre per capire se e come la slow violence possa contribuire a creare sensazionalismo nella comunicazione di stampo scientifico, esplorandone la percezione in un piccolo campione di professionisti, senza la pretesa di proporre delle tesi o di giungere a conclusioni rappresentative di una tendenza certa”.
Allo studio hanno aderito 20 giornalisti e comunicatori della scienza che, nell’arco di un mese, si sono narrati in forma anonima e volontaria. L’invito prevedeva la risposta a 29 stimoli narrativi elaborati secondo la metodologia della medicina narrativa.
Ha risposto una netta prevalenza di donne (solo tre gli uomini) del Nord Italia, in un’età compresa fra i 31 e i 50 anni, con un’esperienza ventennale nel settore, per lo più freelance e con collaborazioni sia nel giornalismo sia nella comunicazione (editoria, aziende sanitarie, agenzie di comunicazione, ecc.). Quasi la metà dei rispondenti tratta temi di salute (medicina, benessere, sanità), a cui fanno seguito quelli di carattere ambientale e scientifici più in generale.
Le narrazioni evidenzierebbero una certa confusione nel cercare di descrivere la slow violence. Quest’ultima è stataricondotta a: scorciatoie, acronimi, inglesismi / parole inesatte, estreme e assolute che implicano un’apparente impossibilità di interpretarle in un modo diverso da quello preponderante / un tradimento per il lettore / sospetto, complotto, accusa / screditamento, denigrazione / condizioni o stati di fatto come inesorabili e definitivi.
Molti sosterrebbero di non ricorrere in alcun modo alla slow violence (no mai / non mi capita mai / non lo faccio capitare) o che sia utilizzata dai colleghi non adeguatamente formati, poco professionali o presi dalla fretta (può capitare che le utilizzi chi non si concentra e non rilegge i testi che ha scritto o non ricorda le regole deontologiche; chi si fa prendere dalla velocità di consegna dei testi e non ricontrolla; chi non è formato in modo adeguato; chi ha un vocabolario scientifico ridotto e una carenza pure di empatia).
La violenza inconsapevole sarebbe percepita anche in certe immagini diffuse dai media, soprattutto quando hanno a che vedere con la salute. In questo caso, viene avvertito il rischio di una possibile spettacolarizzazione o strumentalizzazione. Di qui il prevalere, in prima istanza, di emozioni a valenza negativa (angoscia, apprensione, irritazione) riportate da giornalisti e comunicatori alla visione di quattro foto.
La metà dei rispondenti individuerebbe della slow violence anche nei rapporti e nelle dinamiche di lavoro, chiamando in causa fenomeni come la discriminazione di genere, specie verso le donne, gli interessi economici e i giochi di potere, la scarsa etica e deontologia, i tempi di lavoro frenetici e gli spazi di scrittura contenuti. È tuttavia forte il richiamo a un impegno più concreto e responsabile per rendere la comunicazione più equa, rispettosa e sostenibile, e scongiurare quelle prassi e quei comportamenti che genererebbero slow violence. In tal senso, le risposte ricevute possono essere lette alla luce di almeno otto dei 17 Obiettivi di sostenibilità (SDGs) dell’Agenda 2030: salute e benessere (goal 3), istruzione di qualità (goal 4), parità di genere (goal 5), lavoro dignitoso e crescita economica (goal 8), ridurre le disuguaglianze (goal 10), lotta al cambiamento climatico (goal 13), pace, giustizia e istituzioni solide (goal 16), partnership per gli obiettivi (goal 17).
Nel complesso, la slow violence viene percepita come un problema reale e, come tale, meritevole di essere portato alla luce.
“Il nostro progetto mostra quanto la slow violence, nonostante corra sottotraccia e non sia nota ai più, rappresenti un problema che i colleghi riconoscono. Gli esempi riportati aprono a varie direzioni, poiché si spazia dall’uso delle parole scritte alle dinamiche di lavoro. Questo ci aiuta a caratterizzare meglio la slow violence e la grammatica con cui si manifesta. Il nostro prossimo passo sarà quello di dare seguito alla richiesta di formazione arrivata in massa dai colleghi, aprendo questa opportunità anche ai portatori di interesse”, conclude Elena Trentin.
In allegato: il file del report completo
Silvia Pogliaghi ed Elena Trentin, giornaliste e comunicatrici scientifiche