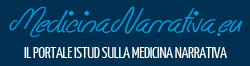Siamo Patrizia Maini e Barbara Del Zotto, entrambe infermiere del Servizio infermieristico domiciliare. Lavoriamo in luoghi distani e diversi, ma con esperienze assimiliabili per tipologia di assistenza e cura.
L’IDEA DEL PROGETTO
L’idea del nostro progetto è nata dal comune interesse di affinare la nostra sensibilità nella relazione e per farlo abbiamo scelto di esplorare, per meglio comprendere e assistere, l’esperienza di malattia e quella di cura di pazienti, familiari-caregiver e infermieri dei servizi infermieristici domiciliari nei quali operiamo quotidianamente come infermiere.
Eravamo alla ricerca non tanto di casi “particolarmente eccezionali”, ma piuttosto di quanto, le storie di tutti i giorni sappiano essere ”normalmente eccezionali”; così ci siamo proposte di esplorare vissuto, bisogni e risorse nelle diverse fasi della malattia e della cura e di analizzarne i punti di convergenza e divergenza attraverso l’analisi di pensieri, emozioni e azioni che facilitano o ostacolano la relazione e il benessere. Quindi, volevamo svelare il non detto attraverso il mai chiesto, toccare il sentito e muoverci tra le storie.
METODOLOGIA
Per raccogliere le storie e riuscire a esplorare le dimensioni che maggiormente ci interessavano, abbiamo costruito una serie di domande guida, diverse per ciascuno dei soggetti inclusi (paziente, caregiver ed infermiere). Queste sono state integrate da una lettera di presentazione dove venivano specificati i nostri intenti, oltre alla volontarietà di adesione e alla possibilità di omettere qualche risposta per fare in modo che la persona che stava contribuendo si sentisse libera di esprimersi e accolta in tutto ciò che desiderasse condividere.
Siamo partite con l’idea che raccogliere storie fosse relativamente semplice, visto che siamo a contatto con i pazienti e le loro famiglie, tutti i giorni. In realtà abbiamo dovuto fare i conti con diversi ostacoli sia legati alle persone e alle loro disabilità, sia legati all’evoluzione della malattia. Nonostante ciò i partecipanti sono stati molto disponibili regalandoci racconti anche molto lunghi e ricchi di dettagli ed emozioni.
Abbiamo letto i testi in modo indipendente analizzandoli con la guida delle indicazioni metodologiche ricevute a lezione.
Speravamo che la progressiva dimestichezza con il contenuto delle storie e il loro stile narrativo ci permettesse di astrarre progressivamente una metodologia di analisi comune, una nostra chiave di lettura, ma questa cosa non è mai accaduta del tutto. Infatti, ciascuna ha inevitabilmente osservato con modalità interpretative proprie, dove la storia personale, le conoscenze e i valori agiscono da lenti di ingrandimento e guida.
Alla fine abbiamo dovuto cedere al fatto che i livelli di analisi non si siano mai esauriti. Le riletture continue, necessarie per comprendere, hanno aperto inesorabilmente sempre nuove prospettive, offrendo a noi la percezione di muoverci con le storie, di subire un processo di cambiamento continuo.
ANALISI
La sintesi finale è emersa nella fusione tra un movimento orizzontale (che abbiamo definito “tra le storie e i ruoli di cura) e uno più verticale che ha aiutato a sondare nel profondo delle storie di ciascun individuo e del suo particolare “ruolo nella cura”.
Dalle narrazioni, i pazienti emergono come persone che osservano e valutano il lavoro dell’infermiere, anche se non hanno ancora del tutto il coraggio di raccontare cosa manca, quale dei loro bisogni non viene visto o indagato, cosa potrebbe essere fatto meglio. Però, a volte, tra le righe, con l’utilizzo di metafore, esprimono i loro sentimenti e richieste. Ad esempio, si riporta una conversazione assistito-infermiere, dono di un paziente in fase terminale di malattia.
Un giorno, sentendo che era arrivato alla fine e nessuno aveva il coraggio di dirgli la verità, si rivolse all’infermiera domandando: “Riuscirò a fare il giro del lago?”. L’infermiera rispose “Non credo che riusciremo a fare il giro del lago” ha risposto l’infermiera.
Il paziente due giorni dopo è andato oltre, ma il potere comunicativo di quella metafora ha superato tutti confini, ha permesso di chiedere una risposta, capire il tempo rimanente e, forse, scegliere.
Ecco il potere delle metafore: veicolano significati, mediano vissuti ed emozioni, senza il bisogno di esplicitare, lasciando spazi aperti di interpretazione e consentendo di entrare nel mondo dell’Altro, con gentilezza, profondità e per rafforzare il legame di cura. Per questo vanno ricercate e anche aspettate nella narrazione orale, dove potrebbero sfuggire via tra gli altri pensieri.
I CAREGIVER
Nel loro racconto sul fare cura, i nostri caregiver si sono rivelati in tutta la loro forza e fragilità. Coloro che si prendono cura in modo diretto del proprio caro, devono essere considerati parte centrale della presa in carico infermieristica perché affrontano la malattia da una prospettiva certamente diversa dal malato, ma complementare a essa e soprattutto con lo stesso peso e la stessa intensità. Sono persone speciali quelle che dedicano la vita alla cura dei loro cari e raccontano storie diverse, con stili diversi, ma esperienze che tra loro trovano anche ampi spazi di similitudine.
Nel nostro caso, si tratta di due donne e un uomo che sanno “fare cura”, talmente immersi nel loro percorso che parlano al plurale quando descrivono la malattia, quasi avessero subito un processo di fusione con il proprio caro:
“Si ammala mio marito …Incominciamo le cure ma non si vedono miglioramenti. Torniamo per un’altra visita….. Conosciamo la dottoressa..ci affidiamo a lei…”.
Tornano poi a pensare al singolare quando ricordano le sensazioni nel momento della diagnosi, quando protagonista era il senso di responsabilità per il trattamento imminente:
“al momento della comunicazione della diagnosi di malattia neurodegenerativa mi crolla il mondo addosso il mio primo pensiero come la affronto? per me è una malattia nuova.”
L’opportunità di scrivere la propria storia è stata colta senza riserve dai caregiver. In alcuni casi ci è sembrato abbia avuto un effetto catartico, di aiuto. Lo stile può essere molto diverso: alcuni offrono un racconto da leggere e capire, chiaro e ordinato. Alltri raccontano quello che hanno dentro, senza filtri. Emerge qui una scrittura articolata e su più livelli, diffiicile da svelare. Una caregiver, in particolare, ci ha posto di fronte alla sua complessità con uno stile narrativo fatto di salti continui tra presente e passato, tra il discorso indiretto (quando era narratrice) e quello diretto di chi sta vivendo la situazione. Ciò ci ha obbligati a continui salti tra l’emozione viva e il suo ricordo, enfatizzato dal raro utilizzo della punteggiatura. Questo fa pensare ad una frase detta di getto, senza respirare che causa un vortice emotivo travolgente.
Gli infermieri, hanno partecipato al progetto con un interesse e una disponibilità tali, che ci sono sembrati addirittura superiori all’atteso. È pensabile che esista negli infermieri un bisogno sommerso, inascoltato di raccontare e confrontarsi sull’esperienza di cura che meriterebbe di essere maggiormente considerato. Una raccolta e condivisione di storie di cura, simile a quella da noi proposta, oltre ad avere una funzione catartica per il singolo, potrebbe essere un potente metodo di apprendimento tra pari. Infatti, condividere le riflessioni sui casi, magari selezionati per patologia, livello di criticità̀ o fasi particolarmente delicate della malattia, potrebbe consentire di diffondere buone pratiche e costruire una cultura organizzativa orientata alla buona cura.
Barbara Del Zotto e Patrizia Maini